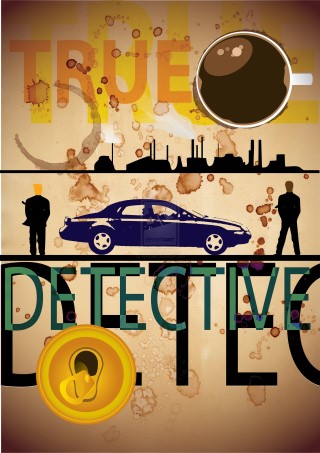
Alla ricerca di significati più o meno nascosti in True Detective, un discreto interesse genera l’ulteriore, apparente dicotomia che lega quarto e quinto episodio.
Il quarto contiene i sei minuti del celeberrimo piano sequenza. E su questo in particolare non mi esprimo oltre, avendone già scritto l’anno scorso, e rimandandovi all’articolo relativo.
C’è però un altro tema, che forse conviene analizzare: Nic Pizzolatto, Cary Fukunaga (che è il regista del piano sequenza), insieme a Jenny Eagan (che invece è la costumista) dialogano del concetto stesso di realtà.
E lo fanno, o l’hanno fatto, coi mezzi che loro hanno a disposizione.
Pizzolatto ha scritto.
Fukunaga ha orchestrato.
Eagan ha aggiunto dettagli decisivi.
La caratteristica che rende il cinema (la televisione, in questo caso) arte corale è che costringe l’autore a scendere a patti con la visione altrui del medesimo oggetto.
È sempre la vecchia storia del messaggio che viene interpretato tante volte quanti sono i lettori dello stesso.
In questo caso Fukunaga ha ideato un piano sequenza, conscio della difficoltà e della possibilità che sarebbe stato costretto, causa scarsa resa, a cestinare tutto. Eppure no, c’è riuscito e ha filmato sei minuti memorabili.
Ma volevo che rifletteste sulla scelta del mezzo.

Il piano sequenza, tralasciando i dettagli meramente tecnici, è paragonabile alla realtà. Fa di tutto per imitarla, negando l’intervento del montaggio che, solitamente, taglia il supefluo.
La dinamicità, l’adrenalina, l’intensità delle scene che vi hanno fatto sognare le dovete, di solito, al montatore, più che al regista.
Il montatore nega la realtà, di fatto correggendola, rendendola più interessante.
Il piano sequenza mette in gioco una collaborazione mostruosa, non a caso poco fa ho adoperato il verbo “orchestrare”, e insiste invece nel senso opposto: questa è una fetta di realtà, così com’è, innegabile, spontanea.
O almeno in teoria, dato che, per l’appunto, il piano sequenza è il risultato ultimo di una perfetta pianificazione.
Tra quarto e quinto episodio ci si riferisce moltissimo al concetto di realtà. Non bastasse il consueto riferimento al Re in Giallo, a Carcosa, alle stelle nere, alla personale visione del mondo detenuta dal serial killer con la maschera antigas, quello che colpisce è questa contrapposizione tra una affermazione così potente del concetto di realtà, che è rappresentata dal piano sequenza, e la relatività della stessa, alla quale si assiste all’inizio del quinto episodio.
In quest’ultimo, Marty e Rust arrivano sulle tracce del serial killer incocciato in chiusura del terzo, mostratoci seminudo, tatuato, con machete e maschera antigas. Marty, che ricordiamo, tra le due personalità è quella saldamente ancorata al mondo materiale, giustizia il sospetto assassino sull’onda dell’impeto: lui ha visto ciò che è stato fatto alle giovani vittime e ha sparato.
Perfettamente in linea con la personalità del personaggio di Woody Harrelson.
Ma ecco che, sistemato velocemente il complice del defunto assassino, Rust (Matthew McConaughey) interviene coprendo il misfatto del collega e, di fatto, costruendo una nuova versione della verità che scagioni entrambi.
Questa manipolazione risulta ancora più potente dal momento che ci viene mostrata sì la verità, ma allo stesso tempo, per bocca dei protagonisti, narrata la versione falsa, che però è quella ufficiale.
La realtà corrisponde, ancora una volta, al modo in cui ce la raccontiamo, nella maniera in cui la intendiamo, o la sogniamo, o nel modo in cui la sfumiamo con la naturale corruzione della nostra memoria.
Pizzolatto e Fukunaga, quindi, sono sulla stessa lunghezza d’onda, il loro dialogo è un dialogo sulla realtà effettuato tramite i mezzi che sono più consoni a ognuno di loro. Perché il piano sequenza non era previsto nella sceneggiatura, è stata un’improvvisazione, che però ha trovato terreno fertile nella filosofia della narrazione.

E infine c’è Jenny Eagan, che in True Detective è quella che sceglie cosa far vestire agli attori, che stabilisce i dettagli, che arricchisce le inquadrature e, in teoria e con la complicità degli altri autori, semina indizi.
Lei spergiura che è tutto casuale.
Che le stelle nere tatuate sul collo di una comparsa e evocate dai deliri dell’omicida con la maschera antigas siano frutto di una coincidenza.
Che l’asciugamano coi minipony indossato dal serial killer sia, al pari della t-shirt dei Pink Floyd indossata da Marty, una decisione dettata dall’estetica e basata, più che altro, sul concetto di spaventoso ottenuto per temi antitetici.
Quanto può essere inquietante vedere un serial killer coperto con un simbolo normalmente associato ai bambini?
E via dicendo.

Tutte le teorie sulle cravatte (l’unica gialla indossata, guarda caso, da uno dei principali sospettati, che lo denuncerebbe come il vero Re in Giallo),
oppure il volto del Re tratteggiato da un folle nei suoi appunti, che però richiama il viso di un altro degli omicidi,
oppure ancora le varie composizioni di uomini che circondano una donna, in foto, tramite bambole e ancora tramite gli omini di latta intagliati dallo stesso Rust,
oltre a costituire, con la loro ritualità, una sorta di liturgia interna alla serie, che poi si richiama alla teoria dell’Eterno Ritorno, rappresentano, di fatto, il messaggio intrinseco.
Non ho alcuna difficoltà a credere a Eagan, e al gioco del caso.
Ma non posso ignorare la casuale coerenza che fa da terzo richiamo alla teoria del concetto di realtà. Seguendo questa teoria, e con la sua orchestrazione operata su più piani, True Detective si presta a molteplici interpretazioni, nessuna delle quali assolutamente corretta, o sbagliata. A cominciare da quella degli stessi autori. Sui quali rimane il legittimo dubbio che se la stiano godendo a dirsi ignari di tutto.

Quindi non ci resta che fissarci sulla maglietta dei Pink Floyd indossata da Marty, e vedere nei due volti che si fronteggiano un simbolo ulteriore di realtà speculare, destinata a ripetersi. E analizzare ogni singolo frame di questo telefilm e trarne fuori altre meraviglie.
È il nostro dono speciale. E il nostro divertimento.




