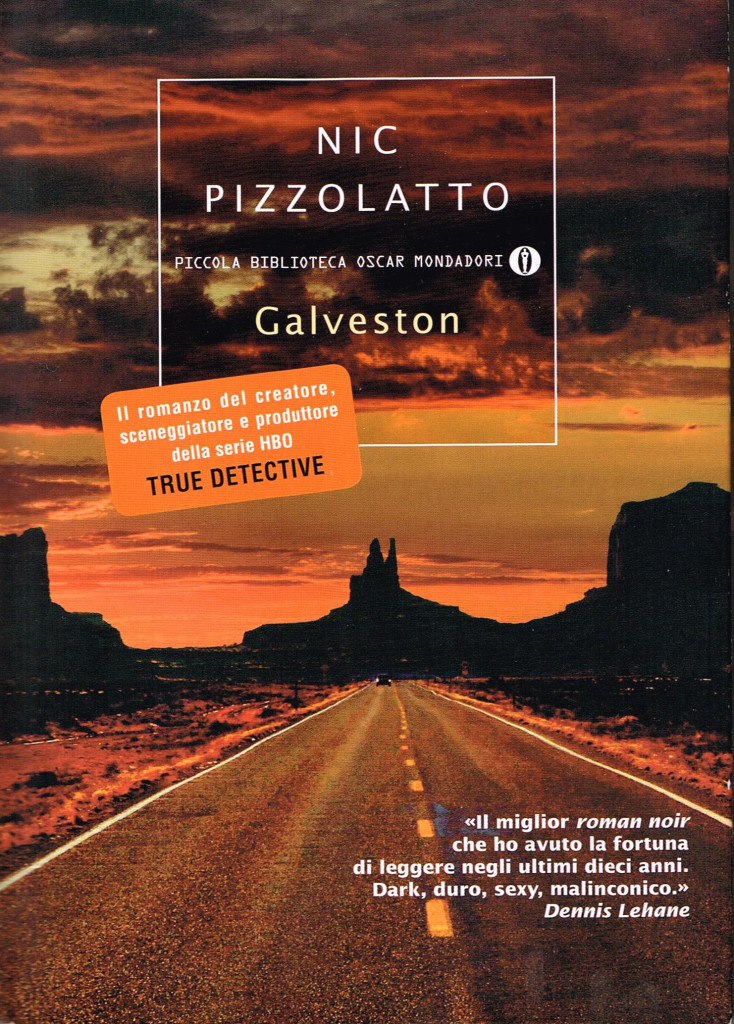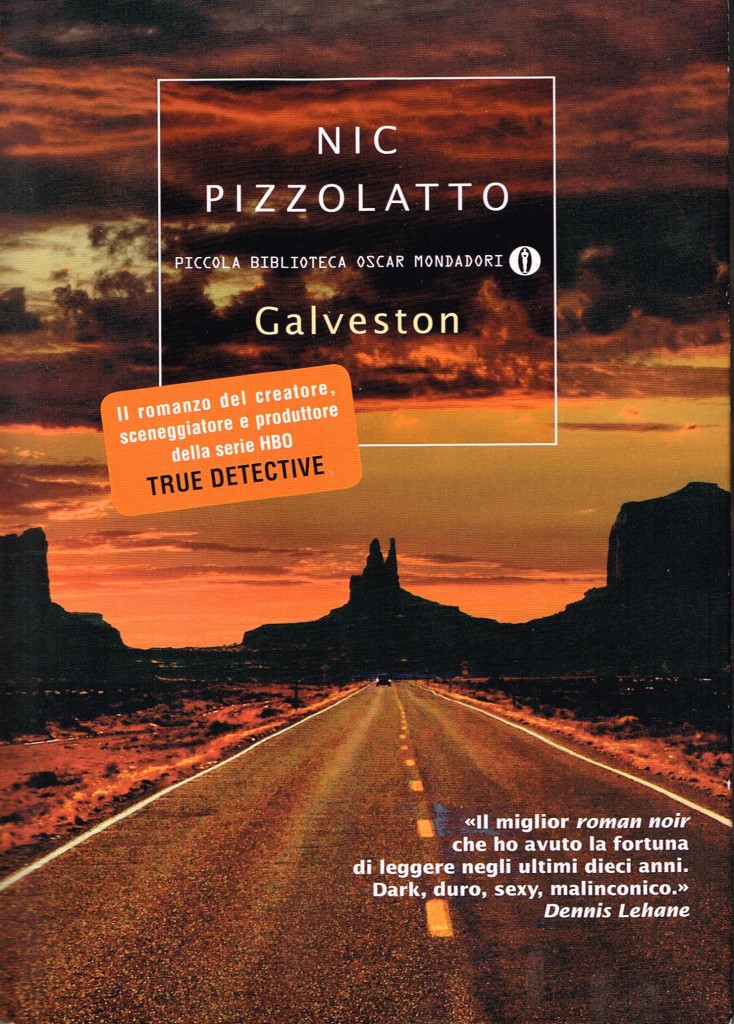 Secondo me, l’errore di Nic Pizzolatto è stato quello di diventare famoso con True Detective. Ovvero con la prima stagione, improntata a un esistenzialismo tendente a due universi filosofico-religiosi: manicheo e nichilista, e che occhieggiava al sovrannaturale, per via delle spesso criticate, per lo più adorate (da me soprattutto), citazioni di Robert William Chambers.
Secondo me, l’errore di Nic Pizzolatto è stato quello di diventare famoso con True Detective. Ovvero con la prima stagione, improntata a un esistenzialismo tendente a due universi filosofico-religiosi: manicheo e nichilista, e che occhieggiava al sovrannaturale, per via delle spesso criticate, per lo più adorate (da me soprattutto), citazioni di Robert William Chambers.
Il pubblico caprone, che è la maggior parte del pubblico, imparate ad amare certe sfumature, scalcia e sbuffa se esse vengono a mancare.
La prima stagione era in realtà l’eccezione alla regola narrativa di Pizzolatto, il racconto sconsiderato, rischioso e spudorato, che avrebbe dovuto essere, forse e meglio, la chiusa di un percorso, non l’inizio.
(Sì, ok, non scalpitate, parleremo anche della seconda stagione, ma non qui.)
Pizzolatto ama l’esistenzialismo puro e semplice. Non indaga sulla natura umana, la tratteggia e ne prende atto, spesso preferendone l’inclinazione drammatica, che è la maggiore, la più frequente.
Lo si associa al noir, perché subito si corre a incasellare. Perché il pubblico capisca, perché si possa vendere su un determinato scaffale, per presentarlo in due righe.
Il marketing.
Galveston è stato d’animo. È ricordo.
È summa poetica delle strane vite dei suoi protagonisti.
È noir nella dannazione degli stessi. È epica nella chiusura del cerchio, di una vita che non è una vita e che attende di raccontarsi per poter morire.
È noir, e molto più di questo.
Pizzolatto abusa del caso, l’abbiamo visto e lo vedremo quando tratteremo altra sua narrativa recente. Un abuso che, in quanto tale, fa storcere il naso. Quando parla di professionisti che rapiscono un uomo e non gli guardano nelle tasche, così che quello stesso uomo riesce a venire fuori da una situazione impossibile.
Ma è solo cornice. Arrivati alla fine di Galveston la si percepisce quasi come non necessaria, per uno scritto che non ha nulla da invidiare, in quanto a dannazione e cittadine sulfuree da dopobomba della provincia americana, a narratori più celebri di anime brutte e polverose.
Il fatto che Roy Cady, il protagonista, sia un gangster che “ne viene fuori”, o che almeno ci prova, è dettaglio superfluo, quasi passibile di eliminazione.
Galveston se ne sta da solo, infuocato come l’alba che trafigge i banchi di nebbia su spiagge di ciottoli, assonnate, come dramma, che è collocato nella testa di un singolo uomo, nei suoi ricordi arresi.
Nic Pizzolatto gioca col genere, lascia intravvedere spiragli di vendetta e poi ribalta ogni cosa, asservito, per una volta in senso positivo, a un realismo che lascia perdonare la storia dei “professionisti” e del coltello a scatto (anche se, a questo riguardo, dovrei verificare sul testo originale; non vorrei si trattasse di ingenuità da parte del traduttore; ingenuità che diventa metodo quando si sceglie di far pronunciare alla protagonista, Rocky, un “None“, che è rafforzativo del “no” nei dialetti italiani del Centro-Sud) e si piega in poetica tragica.
Là dove la trama deraglia c’è la vita, con le sue pause, con la sua contraddizione e tutta quella serie infinita di bivi, di scelte, che ne condiziona riuscita e durata.
Eppure, di narrazione si tratta. Non si sfugge alla tentazione strutturale e alla consapevolezza di non avere a che fare con personaggi reali, per quanto benissimo caratterizzati, ma con archetipi che svolgono, ciascuno di essi, funzione determinata.
Roy Cady diviene così il custode di tante, troppe memorie, un custode morente la cui fine attende solo il giusto momento, perché tutto si compia a dovere, perché l’horror vacui costruito da esistenze misere abbia, di colpo, in un pomeriggio temporalesco, il giusto compimento.

E, se ciò non bastasse, il tratteggio di Galveston e delle sue spiagge ricche di granchi, come un ritiro pacifico dove andare in pausa dal fato, una pausa che può durare anche vent’anni, vale, da solo, la lettura.
La storia di sordida dannazione che circonda questo asilo, solo, impreziosisce.
Curiosità resta circa l’edizione originale. Paiono, i nostri editori, far di tutto per spingere i lettori a cominciare a leggere dall’inglese, sfanculando i traduttori, così come abbiamo imparato a fare al cinema e in TV, coi doppiatori (“i doppiatori più bravi del mondo” Cit.).