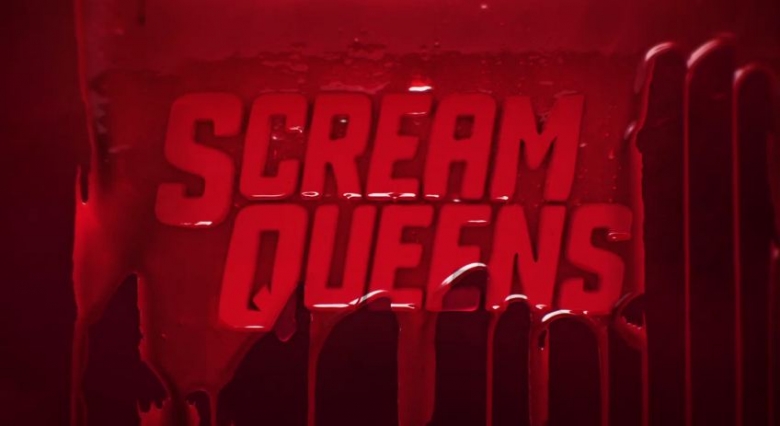 Uno dei miei argomenti preferiti è la narrazione. Spesso, su questo blog mi sono trovato a discutere di narrazione quale “finzione realistica”.
Uno dei miei argomenti preferiti è la narrazione. Spesso, su questo blog mi sono trovato a discutere di narrazione quale “finzione realistica”.
In quanto tale, è vero, la narrazione consente la sospensione dell’incredulità, ci consente di immedesimarci. Il difetto di certa narrazione è che tende a essere o troppo realistica, come nel caso di True Detective, che si piega al realismo sciatto, diventando noiosa esattamente come la vita reale, o il suo contrario, American Horror Story Freakshow, che pretende attraverso una messinscena sontuosa e pacchiana di sublimare attraverso l’horror tematiche sociali.
Esperimenti a modo loro interessanti, ma che non ho condiviso per sistema e esito.
Considero questi due titoli estremi opposti.

Scream Queens, nuova serie di Ryan Murphy, giunta al terzo episodio, al contrario, si sta rivelando esperimento narrativo interessantissimo.
Assistiamo, attraverso le gesta di una sorellanza universitaria, la KKT, capeggiata dalla dispotica Chanel (Emma Roberts) alla quintessenza della tecnica narrativa.
È un racconto, Scream Queens, che ruota attorno a omicidi seriali perpetrati da un individuo mascherato, il Diavolo, che non cela la propria natura di orpello cantastorie, ma la ostenta.
In questo senso, richiama alla mente quell’ardito esperimento di tecnica sopraffina e mescolanza di cliché cinematografico-narrativi che è stato Scream (1996) di Wes Craven (del quale parleremo), e lo esalta attraverso una messinscena ipertrofica.
L’ho definito su facebook come uno “Scream sotto anfetamine”, per l’evidente analogia del massacro con armi da taglio, per l’assassino mascherato, per la costante dell’urlo affidato a giovani attrici, reginette del cinema di serie B, quello di sangue e frattaglie e, pardon, dell’orrore suggerito, evocato dall’atmosfera.
Questo è l’horror dove la ragazzina in maglietta succinta, che qui è griffata Karl Lagerfield, va fuori sotto il portico perché ha sentito un rumore anziché barricarsi.
La Scream Queen è strumento di certo orrore barocco.
Scream Queens è rappresentazione scenica di tale orrore.
Non c’è pretesa alcuna di realismo, che è poi il dettaglio fondamentale, che fa dell’intera operazione tentativo unico, né rispetto alla scenografia, che è talmente artificiale da dare l’impressione di assistere, in certi frangenti, a scene recitate sul palcoscenico, né rispetto ai temi trattati.
 Ora, la messinscena è lussuosa, psichedelica, fintissima. Il trionfo del kipple, di una branca particolare del kipple, quella dei rifiuti hollywoodiani, che sono affastellati nei vecchi e polverosi magazzini degli studios, cimeli, memorabilia, costumi, rimasugli dai set, sceneggiature che nessuno ricorda più, ma che un tempo hanno brillato sotto gli occhi di bue.
Ora, la messinscena è lussuosa, psichedelica, fintissima. Il trionfo del kipple, di una branca particolare del kipple, quella dei rifiuti hollywoodiani, che sono affastellati nei vecchi e polverosi magazzini degli studios, cimeli, memorabilia, costumi, rimasugli dai set, sceneggiature che nessuno ricorda più, ma che un tempo hanno brillato sotto gli occhi di bue.
Le attrici, tra cui Jamie Lee Curtis, veterana delle scream queens dai tempi di Halloween, sono state allenate a urlare, tramite apposite sedute d’allenamento. A camminare come marionette, avendo in testa (su consiglio di Ryan Murphy), qualche musichetta particolare, che evocasse nel loro subconscio un certo ritmo di falcata, pescato direttamente dalle Hits degli anni Novanta. Le citazioni musicali a questo periodo storico, tra l’altro, abbondano.
I temi. Quella dei temi è una faccenda intrigante.
Una sporca faccenda.
La società portata in scena in Scream Queens è la nostra. Coeva, veloce, stupida, ambiziosa, arrogante, razzista, rincoglionita dai social network.
È vero. Siamo così. Siamo ipocriti nel fondare le nostre esistenze sui pregiudizi dei nostri nonni, nel non riuscire a liberarcene. Ma quando lo facciamo, e decidiamo di vivere finalmente come avvremmo dovuto fare da sempre, ci accorgiamo che il mondo attuale è variopinto, ricchissimo di diversità, talmente fantastico da imbastirci su una commedia nera, con un assassino mascherato da diavolo rosso, e riderci su, scatenare lui e le protagoniste con ritmi e frasi da fumetto, o da soap opera. Trattare temi scottanti con normalità. Costruire personaggi e situazioni col semplice montaggio, col susseguirsi di scene elettriche su scene, rinunciando a qualsiasi spiegazione che non sia la semplice intuizione.
Ottimo, ricco, fatiscente e superbo.
Farà storcere il naso a tanti. Sarà uno spettacolo.
 E infine, mi permetto un’ultima considerazione: ho il sospetto che, al di là, quindi, del trionfo della narrazione come entità astratta atta a creare storie e situazioni, vere e proprie funzioni, Murphy stia inscenando una sorta di conflitto generazionale tra i ragazzi degli anni Novanta (che poi tra loro ci sono pure io, che precisamente nel ’94 compivo 18 anni) e quelli dei Dieci.
E infine, mi permetto un’ultima considerazione: ho il sospetto che, al di là, quindi, del trionfo della narrazione come entità astratta atta a creare storie e situazioni, vere e proprie funzioni, Murphy stia inscenando una sorta di conflitto generazionale tra i ragazzi degli anni Novanta (che poi tra loro ci sono pure io, che precisamente nel ’94 compivo 18 anni) e quelli dei Dieci.
Contlitto generazionale che, pur nella burla e nella artificiosità, porta a confronti e conclusioni inedite.
Al cinema di questi tempi è il trionfo del desaturato anni Settanta, quasi che il mondo, nel 1976, fosse sbiadito come la carta kodak delle fotografie. Sarà, ma io me lo ricordo meglio, più vivace.
È la prima volta che si guarda indietro ai Novanta non tanto nella rappresentazione (ché sembra ieri di vedere le impalcature a sorreggere i capelli di Brandon e Dylan, e le cotonature di Kelly e Brenda), ma nella personalità di chi ci è passato, ricco di ambizioni e confusione e s’è ritrovato, vent’anni dopo, a quarant’anni, avendo realizzato poco o niente, grazie ai vecchi che hanno creato e gestiscono il sistema, ma che serba, a differenza della generazione Dieci, la sorellanza K, una sorta di testarda ambizione di essere migliore.
Gli anni Dieci sono pratici, appaiono e svaniscono nell’arco di un click. Si accettano omicidi, sangue in diretta TV, sono la norma. Ok, è una distopia, e noi ci siamo dentro. Possiamo uscirne solo se lo vogliamo. Combattendo.
E quelli che combattono, sono nati e cresciuti qualche decennio prima. Romantici del cazzo.

