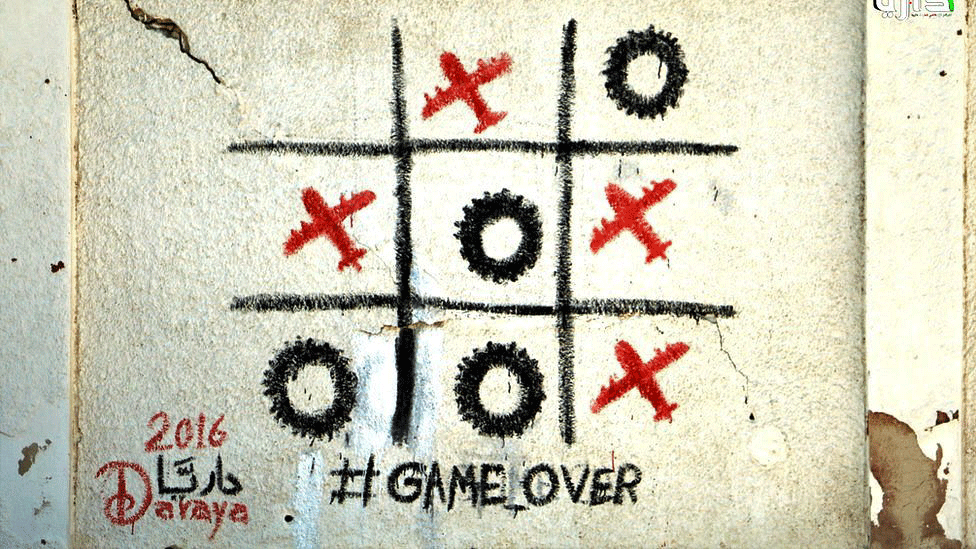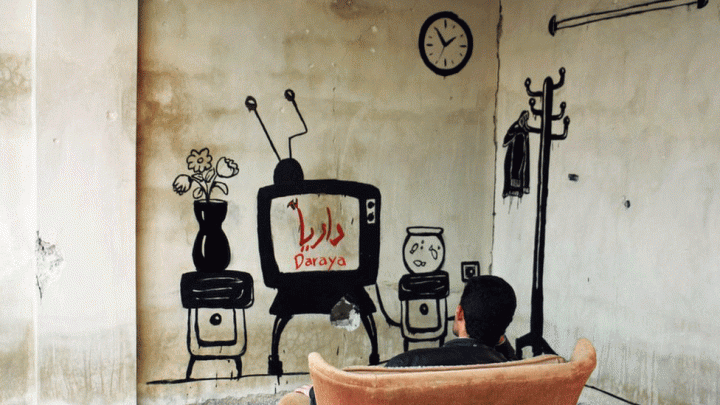La natura del problema è sempre caratterizzata dall’ambiente in cui viviamo.
L’Occidente ha un problema: è vittima di ignoranza capillare e alienazione diffusa.
Oltre che razzismo nascosto, odio, indifferenza…
Le visioni dei nostri artisti ci sussurrano di annientamento dell’essere, sociale e biologico, in luogo di una preferenza quasi assoluta per il trasferimento virtuale.
Siamo a nostro agio, veri, solo attraverso la rete.

Ma ci sono altri luoghi, più… complicati.
Darayya, in Siria.
Da almeno quattro anni al centro di una guerra.
Inutile spendere frasi retoriche: nessuno di noi può capire cosa si provi a essere sotto i bombardamenti. Quelli li hanno vissuti i nostri nonni e i nostri padri, da bambini.
Mio papà ricordava i bombardamenti inglesi a tappeto, di notte, sulla città. Ricordava il buio, ché tutti dovevano spegnere le luci, per non essere individuati e fatti saltare in aria dai bombardieri (era l’epoca pre-radar). Ricordava la neve nera che cadde in Puglia, sulle colline, nell’inverno del ’40.
Nera perché mista a cenere. La cenere degli incendi causati dalle bombe.
Ricordava, soprattutto, Radio Londra. Le trasmissioni degli Alleati. Era un reato ascoltarla. Ma era anche l’unico canale attraverso cui ricevere informazioni veritiere sullo stato del conflitto, in una nazione sempre più preda del delirio negazionista del regime.

Mio padre ha perso tutti i denti in età adulta, perché, da bambino, per anni, gli anni della guerra, si era alimentato con ciò che era riuscito a trovare e che, spesso, non era molto di più di una patata bollita e qualche carruba.
Le carrube erano il cioccolato degli anni Quaranta del Novecento.
Disvitaminosi, si chiamava.
I denti caddero uno dopo l’altro.
Però ha donato a me, nato negli anni della Milano da Bere, dei denti fortissimi.
Abu Malik al-Sham, a Darayya, vive sotto i bombardamenti. È più giovane di me, era solo un ragazzo nel 2011, più o meno al sorgere del conflitto siriano.
Viveva a dieci chilometri dal centro di Damasco.
Ci vive ancora.
Forse non può, magari non vuole lasciare quei territori.
Forse non lo farei neanch’io. Proprio come mio papà, che nonostante i bombardamenti delgi inglesi, non andava via.
D’altronde, all’epoca, dove avrebbe potuto andare?
Se è vero che sono le nostre azioni a riecheggiare nell’eternità, se quello che conta del nostro passaggio è la memoria, si può scegliere di non subire passivamente le angherie di un periodo storico nefasto, e di lasciare comunque una traccia. Per quanto piccola e effimera.
Abu Malik al-Sham, dall’estate 2014, fino all’estate 2016, lascia traccia di sé, a Darayya, attraverso murales e graffiti.
Macchie di colore tra le macerie.
Testimonianza storica attraverso immagini ad alto impatto.
Una bambina che insegna l’amore a un soldato.
Un’altra che scrive la parola “speranza” (Hope) sopra un cumulo di teschi umani.
Una scena domestica, un mobile TV, l’orologio alla parete, un salotto qualunque, dipinto su un muro superstite di una casa sventrata.
E l’evoluzione, anno dopo anno, dalle marce di protesta siriane fino alla nascita dello Stato Islamico. L’ISIS.
Quest’ultimo, con la figura nera, incappucciata, che imbraccia un mitra, nel 2014, mi dà i brividi.
Graffiti sotto le bombe, destinati, forse, a scomparire. Sgretolati da altre bombe, o forse cancellati quando e se ci sarà mai una ricostruzione, partita da una pace che non giungerà mai troppo presto.
La nostra vita è testimonianza, interpretazione del sentire comune, traccia di un momento storico, nel futuro.
Immagino la mia vita tranquilla, il mio divano, il mio PC sul quale aggiorno mollemente questo blog, tutto improvvisamente devastata, tento di teorizzare le mie reazioni.
Non ci riesco.
Non ci si riesce mai.
Si vive. E basta. Al meglio delle nostre possibilità, al netto dei nostri problemi.
A misura d’uomo.
*
(fonte: BBC)